Opere principali[modifica | modifica wikitesto]
| Per approfondire, vedi Opere di Gabriele D'Annunzio. |
La produzione letteraria di D'Annunzio fu stampata integralmente fra il 1927 e il 1936 da un Istituto nazionale creato appositamente sotto l'egida dello Stato italiano per la pubblicazione della sua Opera Omnia. Il Vate collaborò attivamente alla realizzazione dell'ambizioso progetto, come collaborò alla pubblicazione di un'edizione economica (L'Oleandro) che ricalcava la precedente, realizzata anch'essa quando egli era ancora in vita, fra il 1931 e il 1937. Subito dopo la sua morte e cioè fra il1939 e il 1942 la Fondazione del Vittoriale degli Italiani provvide a ristampare quasi integralmente la produzione dannunziana: 42 volumi su un totale di 46 (gli ultimi quattro non uscirono per le note vicende belliche che desolarono l'Italia nel 1943). Nel secondo dopoguerra merita una particolare menzione la pregevole edizione dell’Opera Omnia apparsa, a partire dal 1950, nei Classici Contemporanei Italiani di Arnoldo Mondadori Editore. Fra le opere più significative di Gabriele D'Annunzio segnaliamo:
- Primo vere
- Canto novo
- Intermezzo di rime
- Il piacere
- L'innocente
- Poema paradisiaco
- Il trionfo della morte
- Le vergini delle rocce
- La città morta
- La Gioconda
- Il fuoco
- Laudi
- Le novelle della Pescara
- La figlia di Iorio
- La fiaccola sotto il moggio
- La nave
- Forse che sì forse che no
- Notturno
- Il libro segreto
- La pioggia nel pineto (celeberrima lirica contenuta nel terzo libro delle succitate Laudi: Alcyone)
Estetismo e pensiero dannunziano[modifica | modifica wikitesto]
| (LA) « Habere, non haberi » | (IT) « Possedere, non essere posseduto » |
| (Gabriele D'Annunzio, massima del padre di Andrea Sperelli ne Il Piacere) | |
Le fonti dell'immaginario d'annunziano[modifica | modifica wikitesto]
Il mondo letterario francese[modifica | modifica wikitesto]
Alcune volte la fortuna di cui un autore gode è il frutto di scelte consapevoli, di una capacità strategica di collocarsi nel centro di un sistema culturale che possa garantirgli le migliori opportunità che il suo tempo ha da offrirgli. D'Annunzio aveva cominciato a "immaginarsi" poeta leggendo Giosuè Carducci negli anni del liceo; ma la sua sensibilità per la trasgressione e il successo dal 1885lo portò ad abbandonare un modello come quello carducciano, già provinciale e superato in confronto a quanto si scriveva e si dibatteva in Francia, culla delle più avanzate correnti di avanguardia - Decadentismo e Simbolismo. Il suo giornale gli assicurava l'arrivo di tutte le riviste letterarie parigine, e attraverso i dibattiti e le recensioni in esse contenuti, D'Annunzio poté programmare le proprie letture cogliendo i momenti culminanti dell'evoluzione letteraria del tempo.[59]
Fu così che conobbe Théophile Gautier, Guy de Maupassant, Max Nordau e soprattutto Joris Karl Huysmans, il cui romanzo À rebours costituì il manifesto europeo dell'estetismo decadente. In un senso più generale, le scelte di D'Annunzio furono condizionate da un utilitarismo che lo spinse non verso ciò che poteva rappresentare un modello di valore "alto", ideale, assoluto, ma verso ciò che si prestava a un riuso immediato e spregiudicato, alla luce di quelli che erano i suoi obiettivi di successo economico e mondano.[59]
La filosofia tedesca e il vitalismo[modifica | modifica wikitesto]
D'Annunzio non esitava a "saccheggiare" ciò che colpiva la sua immaginazione e che conteneva quegli elementi utili a soddisfare il gusto borghese e insieme elitario del "suo pubblico". D'altronde, a dimostrazione del carattere unitario del "mondo dannunziano", è significativo il fatto che egli usò nello stesso modo anche il pensierofilosofico, soprattutto tedesco.[59]
Fra i filosofi contemporanei più letti in Europa negli anni 1880 e 1890 furono senza dubbio Schopenhauer e Nietzsche. Da quest'ultimo soprattutto lo scrittore trasse alcuni importanti spunti e motivi per nutrire un universo di sentimenti e valori che appartenevano già a lui da sempre, e che facevano parte dell'atmosfera culturale che si respirava in un continente agitato da venti di crisi nazionalistiche, preannunzio della Grande guerra.[59]
Molto si è discusso su un preteso stravolgimento della filosofia nietzschiana da parte di D'Annunzio, ma tali elucubrazioni in realtà non hanno ragione di essere. La scoperta di Nietzsche da parte del poeta abruzzese non avviene infatti sul piano ideologico, ma si configura come una suggestione letteraria[12]. Le preoccupazioni del Vate erano infatti di indole artistica, non filosofica. D'altra parte il pensiero di Nietzsche, pur essendo stato talvolta oggetto di una generica adesione da parte di D'Annunzio, non fu mai sviluppato organicamente nelle creazioni del Vate che oltretutto non ebbe mai la pretesa di interpretarlo.[59]
In particolare, la rielaborazione della figura del superuomo da parte di D'Annunzio avviene secondo una visione personale e una sensibilità che non sono quelle del filosofo tedesco. I raffinati esteti che popolano i romanzi dannunziani sono ben lontani dall'oltreuomo nietzschiano che raggiunge una conoscenza superiore perseguendo un cammino personale e una dura disciplina di vita. D'Annunzio, nonostante si fosse dichiarato ateo in gioventù[60][61], era affascinato dalle varie culture religiose, sia dalpaganesimo sia dal cristianesimo (in particolare dal francescanesimo) fino all'occultismo e al panteismo, interpretate in un modo personalissimo, e non mutuò quindi da Nietzsche gli aspetti di nichilismo derivati dal concetto della morte di Dio, proclamata dal tedesco; adottata una visione agnostica in campo religioso[62], come quella del collega Pascoli, probabilmente si riavvicinò alla fede negli ultimi anni di vita.[63][64] Da ciò il suo panismo e il suo vitalismo, che permea tutta la sua opera: la pulsione vitale e sensuale che spinge l'esteta-superuomo alla conoscenza piena e alla fusione nel mondo e nella natura.[59]
I nuovi modelli narrativi[modifica | modifica wikitesto]
La scelta di nuovi modelli narrativi e soprattutto linguistici - elemento questo fondamentale nella produzione dannunziana - comportò anche, e forse soprattutto, l'attenzione verso nuove ideologie. Ciò favorì lo spostamento del significato educativo e formativo che la cultura positivista aveva attribuito alla figura dello scienziatoverso quella dell'artista, diventato il vero "uomo rappresentativo" di fine ottocento - primo novecento: "è più l'artista che fonde i termini che sembrano escludersi: sintetizzare il suo tempo, non fermarsi alla formula, ma creare la vita".[59]
L'amore per la Duse[modifica | modifica wikitesto]
Spregiudicatezza e narcisismo, slanci sentimentali e atteggiamenti dettati da puro calcolo furono alla base anche dei rapporti di D'Annunzio con le numerose donne della sua vita. Quella che sicuramente più di ogni altra rappresentò per lo scrittore un nodo intricato di affetti, pulsioni e di artificiose opportunità fu Eleonora Duse, l'attrice di fama internazionale con cui egli si legò dal 1898 al 1901. Non c'è dubbio infatti che a questo nuovo legame debba essere fatto risalire il suo nuovo interesse verso il teatro e la produzione drammaturgica in prosa (Sogno di un mattino di primavera, La città morta, Sogno di un tramonto D'Autunno, La Gioconda, La gloria) e in versi (Francesca da Rimini, La figlia di Iorio, La fiaccola sotto il moggio, La nave e Fedra). In quegli stessi anni, la terra toscana ispirò al poeta la vita del "signore del Rinascimento fra cani, cavalli e belli arredi", e una produzione letteraria che rappresenta il punto più alto raggiunto da D'Annunzio nel repertorio poetico.[59]
Poetica[modifica | modifica wikitesto]
Il percorso poetico di D'Annunzio, cominciato precocemente con Primo vere (1879), raccolta non priva di interesse e che si ispira all'opera carducciana, trova una sua prima autonomia espressiva in Canto novo, dove già si iniziano chiaramente a delineare alcune componenti essenziali della sua arte: la capacità di assimilare e rielaborare in forme del tutto personali le suggestioni e gli stimoli più svariati, provenienti sia dalla storia e dalla mitologia sia dalle correnti letterarie e filosofiche contemporanee; una visione vitalistica e sensuale della realtà di matrice classica o classicheggiante; l'elaborazione di un linguaggio il cui splendore e preziosità suggestiona e seduce ed è esso stesso parte integrante di un mondo poetico espresso da una sensibilità squisita e raffinata.[59] Tali componenti saranno ulteriormente sviluppate e approfondite nelle raccolte poetiche successive e in particolare nelle Elegie romane (1892), caratterizzate da un gusto eclettico di matricedecadentista in cui traspaiono gli echi più eterogenei, da Ovidio a Dante e Petrarca, da Goethe (che qui costituisce il modello per D'Annunzio sotto il profilo metrico) a Algernon Swinburne.
Nel 1903 vennero pubblicati i primi tre libri delle Laudi, che secondo molti critici costituiscono il momento più alto dell'arte dannunziana e forse l'opera in versi più celebre e celebrata di D'Annunzio. In particolare nell'Alcyone, si riflettono i momenti più felici della sua panica immersione nelle atmosfere dell'antichità classica (Ditirambi, L'oleandro), in quelle della sua terra di origine, l'Abruzzo (I Pastori) e, soprattutto, nei paesaggi toscani del Valdarno (Bocca d'Arno), del Pisano e della Versilia (La pioggia nel pineto).[59] Ai consueti stimoli letterari (Ovidio, Dante, Carducci, i simbolisti, ecc.) e filosofici (in primo luogo Nietzsche) si aggiungono nell'Alcyone i sussidi derivanti da letture più tecniche (dal dizionario botanico di Caruel ai trattati di agricoltura del Palladio)[65] che fanno della raccolta un unicum nel panorama poetico del Novecento europeo. Per taluni critici l'Alcyone comincia ad aprire la strada a un altro capolavoro assoluto del D'Annunzio maturo: il Notturno. Fondamentale nell'Alcyone è la musicalità della lirica dannunziana, con l'ampio uso di parole onomatopeiche[59], come ne La pioggia nel pineto:
| « Taci. Su le soglie / del bosco non odo / parole che dici / umane; ma odo
parole più nuove / che parlano gocciole e foglie / lontane. »
|
D'Annunzio e Giovanni Pascoli, l'altro grande poeta del Decadentismo italiano, si conoscevano personalmente, e, benché caratterialmente e artisticamente molto diversi, il Vate stimava il collega e recensì positivamente le liriche pascoliane; Pascoli, dal canto suo, considerava D'Annunzio come il suo fratello minore e maggiore. Alla morte del Pascoli (1912) D'Annunzio gli dedicò l'opera Contemplazione della morte.[59]
La narrativa dannunziana[modifica | modifica wikitesto]
Le giovanili Novelle della Pescara si ispirano al Verga pur presentando la propria gente abruzzese in uno stile barbaramente violento.[59]
D'Annunzio raggruppò i suoi romanzi in tre cicli[59]:
- i "'romanzi della rosa"' (Il Piacere, L'innocente, Il trionfo della morte), che rappresentano lo sforzo per vincere la sensualità di fronte alla quale però cedono i protagonisti (rispettivamente Andrea Sperelli, artista raffinato vinto dall'amore per Elena Muti; Tullio Hermil che, nonostante la pietà umana, farà morire l'innocente nato da una relazione con la moglie; Giorgio Aurispa dominato dalla lussuria);
- i "romanzi del giglio", che rappresentano la purificazione dalla passione: scrisse solo Le vergini delle rocce, il cui protagonista, Claudio Cantelmo, è incerto fra tre fanciulle, quale sarà degna di generare il superuomo futuro rigeneratore della stirpe latina;
- i "romanzi del melograno", simbolo della rinata volontà: scrisse solo Il fuoco, in cui il protagonista Silvio Effrena riceve dalla giovane Foscarina l'ispirazione per la sua opera teatrale.
La struttura "ciclica" dei romanzi fu ideata anche da altri scrittori, per esempio Honoré de Balzac (i "cicli" de La Commedia umana); Verga (Ciclo dei Vinti); Fogazzaro(tetralogia: Piccolo mondo antico, Piccolo mondo moderno, Il santo, Leila); Émile Zola.
Estranei ai tre cicli sono il romanzo Giovanni Episcopo, che risente dello psicologismo della narrativa russa (in particolare Fëdor Dostoevskij), e Forse che sì forse che no, che esalta il mito eroico dell'aviazione.[66]
Oratoria politica[modifica | modifica wikitesto]
| « Italia, Italia, / sacra alla nuova Aurora / con l’aratro e la prora! » |
| (Canto augurale per la nazione eletta[67]) |
Negli anni immediatamente precedenti il Primo conflitto mondiale, nella mentalità collettiva e negli ambienti culturali di tutta l'Europa si affermò un diffuso atteggiamento ottimistico e di esaltazione, non di rado accompagnato da contenuti politico-ideologici. Questo stato d'animo generale, legato al clima culturale della Belle Époque d'inizio secolo, fu poi ribattezzatoSuperomismo, sulla base di una lettura personale dei testi di Nietzsche; tutt'oggi il dibattito su quest'argomento non è ancora concluso. D'Annunzio intuì lo smisurato potere che si può trarre dai mezzi di comunicazione di massa e compartecipò a questo fenomeno fino a divenirne uno dei maggiori propugnatori.[59]
Il piacere fisico e gestuale della parola ricercata, della sonorità fine a sé stessa, della materialità del suono proposta come aspetto della sensualità, aveva già caratterizzato la poetica delle Laudi; ma con le opere teatrali egli aveva maturato uno stile il cui scopo era conquistare fisicamente il pubblico in un rapporto sempre più diretto e meno letterario. Facendo leva sul mito di Roma e su una vasta mitologia nazionale post-risorgimentale, creò un modulo retorico dall'aspetto al contempo combattivo ed elitario: l'abbandono della prosa letteraria e l'immersione nel rito collettivo della guerra si presentò come un tentativo di conquistare la folla, da un lato per dominarla dall'altro per annullarsi in essa, nell'ideale comunione totale tra capo e popolo. E in queste orazioni il popolo prendeva le forme impressionistiche dell'«umanità agglomerata e palpitante», mentre il capo era un re-filosofo, ora riproposto come profeta della patria.[59]
La retorica bellica di D'Annunzio trovò un largo consenso nella popolazione, affascinata dal suo carisma e dall'aura di misticità che lo circondava. Egli elaborò in questo modo un immaginario per la propaganda interventista, la quale sarà la premessa e il prototipo della propaganda fascista nel primo dopoguerra.[59]
| Per approfondire, vedi Motti dannunziani. |
D'Annunzio e la musica[modifica | modifica wikitesto]
Sin dall'infanzia, Gabriele D'Annunzio ebbe un rapporto strettissimo con la musica, tanto da prendere lezioni di pianoforte e contemporaneamente di violino dietro suggerimento del padre. D'Annunzio possedeva un violino prodotto probabilmente da Jakobus Steiner (1617 - 1683), uno dei più illustri liutai del Tirolo.[68] Il Vate era più legato a Gasparo da Salò che al sommo Antonio Stradivari. L'amore per Gasparo da Salò e per il violino è rintracciabile anche nelle stanze e nei giardini del Vittoriale. Nella villa diGardone Riviera c'è una parte del giardino che ha la forma di un violino ed è chiamata giardino delle danze. La stanza della musica, quella che ospitava le esecuzioni intime di Luisa Baccara al pianoforte, recava inizialmente il nome di Camerata di Gasparo , proprio in onore al padre del violino moderno.[68] D'Annunzio sapeva suonare anche la chitarra e spesso trascorreva il pomeriggio con essa. Era un finissimo conoscitore dell'opera musicale: privilegiava il sinfonismo di Ludwig van Beethoven, la poesia pianistica diFryderyk Chopin e di Robert Schumann, il lirismo di Giuseppe Verdi e non dimenticava mai di prestare attenzione anche ai capolavori e alle innovazioni della sua epoca. Disdegnava la banda di Pescara, da lui definita brigantesca e si concentrava all'ascolto dei quintetti sgambatiani che Giovanni Sgambati, discepolo di Franz Liszt, teneva a Roma nella Sala Dante, alla presenza della Regina Margherita.[68]
Amicizie, collaborazioni ed inimicizie[modifica | modifica wikitesto]
Era intimo amico di Francesco Paolo Tosti, il cosiddetto Re della romanza. D'Annunzio fornì a Tosti numerosi testi da musicare. Il più famoso è senz'altro uno dei capolavori della canzone napoletana: A vucchella. Scritta da D'Annunzio nel 1892, in seguito ad una scommessa con Ferdinando Russo al tavolino del Caffè Gambrinus di Napoli, divenne un successo internazionale quando fu cantata da Enrico Caruso.[68] Russo diede il testo a Tosti che lo musicò e la celeberrima canzone fu pubblicata da Ricordi nel 1904 con la sua data di composizione. Tra le altre romanze di Tosti, con i versi di D'Annunzio, merita d'esser ricordata anche L'alba separa dalla luce l'ombra , famosissima lirica tratta dalle Quattro canzoni dell'Amaranta. D'Annunzio intuì il valore dell'opera verista, ma fu sempre riluttante nei suoi confronti. Definì Pietro Mascagni il capobanda e scrisse un pamphlet dallo stesso titolo che apparve su Il mattino di Napoli il 3 settembre 1892. D'Annunzio reclamava un ritorno all'antica musicalità d'origine classica.[68]
Divenne amico di Giacomo Puccini e col grande compositore si tentò la collaborazione per comporre due drammi storici: Rosa di Cipro e La crociata dei fanciulli. Il carteggio tra i due, di recente pubblicazione, mostra proprio queste due forze culturali, tutte tese a entrare in contatto per creare un assoluto capolavoro.[68]
D'Annunzio legò anche con Arturo Toscanini e memorabile è il concerto che Toscanini tenne con l'orchestra del Teatro alla Scala nel 1920 a Fiume. D'Annunzio scrisse a Toscanini nel giugno di quell'anno:«... Venga a Fiume d'Italia, se può. È qui oggi la più risonante aria del mondo. E l'anima del popolo è sinfoniale come la sua orchestra. I Legionari attendono il Combattente che un giorno condusse il coro guerriero».[68] Toscanini fu accompagnato nella città dannunziana da Leone Sinigaglia e Italo Montemezzi. La città di Fiume era una sorta di città musicale. La musica era la più intima compagna dei cittadini e nello statuto della città v'era scritto:«Excitat auroram», eccita l'alba.[68] D'Annunzio disse ai suoi legionari dopo l'esercitazione del mattino:«Guardatelo, guardategli la mano che tiene lo scettro. Il suo scettro è una bacchetta, leggera come una verga di sambuco; e solleva i grandi flutti dell'orchestra, sprigiona i grandi torrenti dell'armonia, apre le cateratte della grande fiumana, scava le forze dal profondo e le rapisce al sommo, frena i tumulti e li riduce in sussurri, fa la luce e l'ombra, fa il sereno e la tempesta, fa il lutto e il giubilo». Quella stessa sera vi fu il concerto che prevedeva musiche di Beethoven, Giuseppe Verdi (I vespri siciliani),Wagner, Sinigaglia (Suite Piemonte) e di Respighi (Le fontane di Roma). Il legame con Toscanini non terminò dopo l'esperienza di Fiume. Il Vate invitava spesso Toscanini e sua figlia al Vittoriale.[68]
D'Annunzio prestò numerosi suoi testi alla scena musicale. La figlia di Iorio fu musicata da Alberto Franchetti, famoso per aver concesso ad Umberto Giordano il testo dell’Andrea Chenier; Francesca da Rimini da Riccardo Zandonai che ne trasse un'opera dal valore autentico, Parisina da Pietro Mascagni, La Pisanella e La Nave ad Ildebrando Pizzetti, il più grande compositore influenzato dal dannunzianesimo assieme a Gian Francesco Malipiero e autore della Sinfonia del Fuoco perCabiria, il kolossal cui aveva collaborato anche D'Annunzio. Non solo agli italiani finirono i grandi capolavori scenici del Vate: le musiche di scena per Fedra vennero composte da Arthur Honegger, mentre Claude Debussy ebbe il privilegio di musicare Il martirio di San Sebastiano.[68], tragedia pagana mista a simboli cristiani.
Composizioni da camera su testi dannunziani[modifica | modifica wikitesto]
- I sonetti delle fate - (Gian Francesco Malipiero)
- La sera fiesolana - (Alfredo Casella)
- La sera - (Ottorino Respighi)
- La najade - (Ottorino Respighi)
- Mattinata (Spandono le campane) - (Ottorino Respighi)
- Sopra un'aria antica - (Ottorino Respighi)
- O falce di luna calante- (Ottorino Respighi)
- Un sogno (Ottorino Respighi)
- Van li effluvi de le rose da i verzieri - (Ottorino Respighi)
- A vucchella (Sì, comm'a nu sciorillo) - (Francesco Paolo Tosti)
- Ancóra qualche rose è ne' rosai (Francesco Paolo Tosti)
- Arcano! (Io credo udir tra li alberi un susurro) - (Francesco Paolo Tosti)
- Buon Capo d'Anno (O dame che le Folgori degli occhi) - (Francesco Paolo Tosti)
- Che dici, o parola del Saggio- (Francesco Paolo Tosti)
- Chi sei tu che mi parli ove non s'ode-(Francesco Paolo Tosti)
- Dorme la selva, e tra l'ombrose fronde-(Francesco Paolo Tosti)
- E quale cosa eguaglia ne la vita-(Francesco Paolo Tosti)
- En hamac (J'entends tomber des branches) - (Francesco Paolo Tosti)
- Visione (Il sole ride: le nubi serene) - (Francesco Paolo Tosti)
- In amaca (Mi cantano i rami) - (Francesco Paolo Tosti)
- In van preghi, in vano aneli - (Francesco Paolo Tosti)
- Arcano!(Io credo udir tra li alberi un susurro) - (Francesco Paolo Tosti)
- Notte bianca (La mia lunga romanza in mi minore) - (Francesco Paolo Tosti)
- L'alba separa dalla luce l'ombra - (Francesco Paolo Tosti)
- Lasciami! Lascia ch'io respiri, lascia - (Francesco Paolo Tosti)
- L'ora è tarda; deserto il mar si frange - (Francesco Paolo Tosti)
- Ma chi vide più larghi e più profondi - (Francesco Paolo Tosti)
- Mentre che fra le tende scolorate - (Francesco Paolo Tosti)
- Mi cantano i rami (In amaca) - (Francesco Paolo Tosti)
- Ninna nanna - (Francesco Paolo Tosti)
- Non pianger più. Torna il diletto figlio - (Francesco Paolo Tosti)
- Or dunque addio! Con le pupille ardenti - (Francesco Paolo Tosti)
- Perché ti neghi con lo sguardo stanco - (Francesco Paolo Tosti)
- Piangi, tu che hai nei grandi occhi la mia - (Francesco Paolo Tosti)
- Quanto ha dormito, il cembalo! Mancava - (Francesco Paolo Tosti)
- Se ancora col più dolce tuo sorriso (Por morire) - (Francesco Paolo Tosti)
- Settembre di': l'anima tua m'ascolta - (Francesco Paolo Tosti)
- Sogna, sogna, mia cara anima! Tutto - (Francesco Paolo Tosti)
- Tanto accadrà, ben che non sia d'aprile - (Francesco Paolo Tosti)
- Vorrei (Vorrei, allor che tu pallido e muto) - (Francesco Paolo Tosti)
- Vuol note o banconote? - (Francesco Paolo Tosti)
- Wenn lichter Mondenschein - (Max Reger)
- Canto dell'ospite (Si frangono l'acque odorose) - (Leone Sinigaglia)
- Sommerfahrt - (Leone Sinigaglia)
Opere teatrali e musiche di scena su soggetti dannunziani[modifica | modifica wikitesto]
- La figlia di Iorio, tragedia pastorale in 3 atti - (Alberto Franchetti)
- Francesca da Rimini, opera drammatica - (Riccardo Zandonai)
- Parisina, tragedia lirica in 4 atti - (Pietro Mascagni)
- Fedra - (Ildebrando Pizzetti)
- La figlia di Iorio - (Ildebrando Pizzetti)
- La Pisanella, musiche di scena - (Ildebrando Pizzetti)
- La nave, musiche di scena - (Ildebrando Pizzetti)
- Phaedre, musiche di scena - (Arthur Honegger)
- Il martirio di San Sebastiano, musiche di scena - (Claude Debussy)
La musica nelle opere di D'Annunzio[modifica | modifica wikitesto]
La maggior parte delle opere scritte da D'Annunzio contiene riferimenti espliciti alla musica. Il piacere divenne ben presto il testo sacro dell'estetismo, assieme alDorian Gray di Wilde e A rebours di Huysmans. Il suo protagonista, l'esteta e raffinato Andrea Sperelli, conosce ad un concerto Elena Muti, la donna che amerà. La cornice dell'innamoramento è Beethoven. La Sonata al chiaro di luna diventa il simbolo ed emblema di un amore che sta scoccando. D'Annunzio immortala il momento magico, fatato, attraverso le note dell'andante sostenuto. Il romanzo contiene altri riferimenti a brani celebri e non. Maria Ferres, la seconda amata di Sperelli, è un'abile pianista che esegue preludi di Bach e pezzi sognanti di Schumann. D'Annunzio sembra quasi farsi beffe dei lettori poco esperti dell'arte: in un passo, si parla di una Gavotta delle dame gialle composta da Jean-Philippe Rameau, ma il francese non ha mai composto nessun pezzo con questo titolo.[68][69]
Ne Il trionfo della morte, Giorgio Aurispa, il protagonista, si imbatte in una stanza del suo palazzo, colma di memorie d'arte musicali[68]: «Nella terza stanza, severa e semplice, le memorie erano musicali, venivano dai muti strumenti. Sopra un lungo cembalo levigato, di palissandro, ove le cose si riflettevano come in una sfera, riposava un violino nella sua cutodia. Sopra un leggio una pagina di musica si sollevava e si abbassava ai soffli dell'aria, quasi in ritmo con le tende. Giorgio si avvicinò. Era una pagina di un Mottetto di Felix Mendelssohn: Dominica II post Pascha... Giorgio aprì la custodia, guardò il delicato strumento che dormiva in un velluto color d'oliva, con le sue quattro corde intatte. Preso come da una curiosità di svegliarlo, egli toccò il cantino che diede un gemito acuto facendo vibrare tutta la cassa. Era un violino di Andrea Guarneri, con la data del 1680. La figura di Demetrio, alta, smilza, un po' curva, con un collo lungo e pallido, con i capelli rigettati indietro, con la ciocca bianca sul mezzo della fronte, riapparve».
Un'altra memoria musicale del romanzo è senza dubbio il ricordo del Tristano e Isotta, in cui il protagonista si getta nella memoria profonda cercando di godere ancora della scena passionale e magica.[68]
Le vergini delle rocce è il suo unico romanzo in cui non compare nessun riferimento preciso alle composizioni, ma la musica qui è data dalla glorificazione della bellezza sonora scaturita dall'acqua[68]:
| « L'acqua non è più l'acqua; diventa un'anima perduta che urla, che ride, che singhiozza, che balbetta, che sbeffa, che si lagna, che chiama, che comanda. Incredibile!, dice Antonello per giustificarsi di avere imposto il silenzio ai giuochi degli zampilli. Ma quando Anatolia richiama a vita la grande fontana marmorea - componimento pomposo di cavalli nettunii, di tritoni, di delfini e di conche in triplice ordine, dandole l'acqua, ecco che il narratore Claudio immagina la voluttà della pietra invasa dalla fresca e fluida vita: e finge in sé medesimo «l'impossibile brivido.
Le buccine dei tritoni soffiavano, dice Claudio, le fauci dei delfini gorgogliavano. Dalla sommità uno zampillo eruppe sibilando, lucido e rapido come un colpo di stocco vibrato contro l'azzurro; si franse, si ritrasse, esitò, risorse più diritto e più forte; si mantenne alto nell'aria, si fece adamantino, divenne uno stelo, parve fiorire. Uno strepito breve e netto come lo schiocco di una frusta echeggiò da prima nel chiuso; poi fu come uno scroscio di risa poderose, fu come un rovescio di pioggia... - Senti, esclamò Antonello che guardava quel trionfo con occhi di nemico - ti sembra tollerabile a lungo questo frastuono ? - «Ah, io starei ore e giorni ad ascoltarlo - parvemi dicesse Violante mettendo su la sua voce un velo più grave - nessuna musica vale questa per me». »
|
| (G. D'Annunzio, Le vergini delle rocce) |
L'opera poetica, infine, è tutta permeata da una musicalità eccezionale, riscontrabile in maniera molto chiara anche nella prosa dannunziana. Le liriche dell'Elettra, invece, contengono alcuni omaggi ai grandi ingegni musicali dell'Italia (Giuseppe Verdi e Bellini). L'Alcyone, però, è il capolavoro della musicalità lirica di D'Annunzio: basti pensare alla grandezza de La pioggia nel pineto, il più grande esempio di partitura musicale dannunziana.[70]
D'Annunzio e Wagner[modifica | modifica wikitesto]
| « ..Nell'orchestra parlavano tutte le eloquenze, cantavano tutte le gioie, piangevano tutti i dolori, che mai voce umana espresse. Su dalle profondità sinfoniche le melodie emergevano, si svolgevano, si interrompevano, si sovrapponevano, si mescevano, si stemperavano, si dileguavano, sparivano per riemergere. [...] Nell'impeto delle progressioni cromatiche era il folle inseguimento d'un bene che sfuggiva ad ogni presa pur da vicino balenando. Nelle mutazioni di tono, di ritmo, di misura, nelle successioni di sincopi era una ricerca senza tregua, era una bramosia senza limiti, era il lungo supplizio del desiderio sempre deluso e mai estinto. » |
| (Il trionfo della morte) |
| « Nel preludio del Tristano e Isolda l'anelito dell'amore verso la morte irrompeva con una veemenza inaudita, il desiderio insaziabile si esaltava in una ebrezza di distruzione. Per bere laggiù in onor tuo la coppa dell'amore eterno, io voleva consacrarti con me sul medesimo altare alla morte. » |
| (Il trionfo della morte) |
D'Annunzio pubblicò tre articoli nel 1893: gli articoli apparsi su “La Tribuna”, il 23 luglio, il 3 e il 9 agosto, erano dedicati a Il caso Wagner. In questi articoli D'Annunzio prende ufficialmente le difese del compositore e va contro Friedrich Nietzsche, uno dei suoi filosofi d'elezione. D'Annunzio difende il lavoro moderno di Wagner e dice: "Il filosofo si mette fuori del suo tempo, mentre l'artefice rientra nel suo tempo. Ma l'uno, pur glorificando la vita, spazia in un dominio puramente speculativo; mentre l'altro realizza le sue astrazioni nella forma concreta dell'opera d'arte.... Pel Nietzsche, quindi, l'autore del Parsifal non è un artefice di musica... egli concede che in questo il Wagner possa a buon diritto apparirci come un creatore e un novatore di primo ordine, avendo infinitamente aumentato la potenza espressiva della musica. Ma la concezione è subordinata all'ipotesi che la musica possa talora non essere musica, sì bene un linguaggio, una specie di ancilla dramaturgica. Togliete la musica wagneriana dalla protezione dell'ottica teatrale - egli dice - e avrete semplicemente della cattiva musica, la peggior musica che sia mai esistita. Qui è il grossolano errore, o la vana ingiustizia. Per me, e per i miei pari, la superiorità di Riccardo Wagner sta appunto in questo: che la sua musica è, in gran parte, bellissima ed ha un alto e puro valore di arte indipendentemente dalla faticosa macchinazione teatrale e dalla significazione simbolica sovrapposta". La musica di Wagner è riccamente citata nelTrionfo tanto che il Tristano diventa fonte di ispirazione per l'opera ma anche follia per il protagonista.[71] Il fuoco è il romanzo in cui la musica troneggia. Uno dei personaggi è addirittura Richard Wagner stesso, vecchio, prossimo alla morte (nel romanzo si fanno anche riferimenti a Claudio Monteverdi, a Caccini, alla sinfonia dell’Arianna di Benedetto Marcello, ma è il compositore tedesco il vero protagonista musicale).[68] D'Annunzio si identifica col protagonista, Stelio Effrena, come uno dei portatori della bara di Wagner, dopo la sua morte avvenuta a Venezia, fatto che in realtà non avvenne, poiché lo scrittore non era nella città lagunare nel febbraio 1883.[72]
D'Annunzio e la cucina[modifica | modifica wikitesto]
| « O Vita, o Vita, / dono dell'Immortale / (...) alla mia fame vorace (...) O mondo, sei mio! / Ti coglierò come un pomo, / ti spremerò alla mia sete, / alla mia sete perenne. » |
| (Inno alla vita, in Laudi, Maia) |
Si racconta come, poco più che adolescente al Collegio Cicognini, D'Annunzio abbia capitanato una rivolta contro la polpetta. Sin dall'inizio il poeta era noto come intenditore di cucina. Al Vittoriale, se doveva prender parte ad un pasto, si isolava nella Stanza della cheli, la sala da pranzo dal pesante decoro in cui troneggia ancora oggi la tartaruga di bronzo, ricavata dal guscio della vera Cheli, la tartaruga del Vate che morì per indigestione di tuberose, monito all'ingordigia. Il Vate amava regalare alle sue amanti dolci, cioccolatini e marrons glacés, di cui era particolarmente ghiotto; non apprezzava molto il vino, preferendo la semplice acqua, da sempre lodata nelle sue composizioni. Ottima è l'acqua: il verso di Piandaro faceva mostra di sé sulle pareti del bagno al Vittoriale. Tuttavia durante il periodo francese bevve il vino (vini di Bordeaux e tra gli champagne il Mumm Cordon Rouge). Per il poeta il cibo è una raffinata e stimolante metafora della seduzione; esso anticipa, richiama o sublima l'incontro d'amore ("La finezza dei cibi aiuta l'armonia mentale", scrisse):
| « ...Scalise, il calabrese, mi ha mandato l’uva passa avvolta nelle foglie legate: quella che già celebrai nella Licenza della Leda. Magicamente la mia sensualità si trasfonde nelle mie dita che cercano gli acini dentro l’involucro. E’ un viluppo femminino. Una voluttà creata dall’immaginazione, nel separare acino da acino, nella massa aderente. L’umidità viscosa come quella della fica dopo il piacere. L’orgoglio di trovare un godimento ancor più profondo e raro, senza la presenza opaca e pesante. Una nuova specie di piacere solitario, inspirato da una Musa che arrossisce e impallidisce a volta a volta?.... » |
| (Di me a me stesso, appendice al Libro segreto) |
Durante gli anni del Vittoriale, i pranzi venivano prodotti da Albina, governante chiamata Aélis, poi Suor Intingola, Suor Albina e Santa Cuciniera, mentre chiamava sé stesso il Priore.[73] Albina ha il compito di esaudire i desideri culinari del Vate, ma anche di reclutare le “badesse”, le donne di compagnia che dovevano soddisfare i gusti sessuali del Comandante.[55]
D'Annunzio fu anche cuoco: sappiamo di una speciale salsa:
| « ...Ti ricordi tu quando scendevamo insieme per la scala portando le bottiglie, i barattoli, e quella famosa saliera uscita dalle fabbriche di Sevres? Ti ricordi com'eravamo allegri e come ridevamo e di quanti baci intramezzavamo la faccenda? Ti ricordi di tutto? E anche di quella salsa miracolosa che io feci una sera pestando per due ore un pezzo di tonno?... E poi, mentre le vaste tazze di caffè fumigavano, tu perseguitavi le farfalle dagli occhi di rubino, che svolazzavano intorno al lume. E io aspettavo impaziente che tu dicessi alla fine: - Vuoi che andiamo? / E allora incominciava un altro piacere... » |
| (da alcune lettere a Barbara Leoni[74]) |
D'Annunzio amava circondarsi di bicchieri di vetro soffiato, laccato, bordato, finemente decorato, di argenti singolari: tartarughe e pavoni segnaposto, tempestati di gemme, passerotti per stecchini, spremilimoni da piatto, pulcini portauovo. Amava il riso, la carne alla griglia quasi cruda, tutti i pesci, pernici e cacciagione e tartufi. Tra i formaggi gustava il cacio e tra i salumi amava il salamino pepato.[75] Mangiava giornalmente 4-5 uova e fu un cultore della bistecca.[76] Divorava la frutta, cotta o cruda, ad ogni pasto e fuori dai pasti. Preferiva le pesche-noci, l'uva, i mandarini, le banane ma soprattutto le fragole. Gli piaceva una macedonia composta di fette d'arancio e qualche goccia di liquore. Quando non era osservato, amava divorare una dozzina di gelati di seguito; il preferito era il sorbetto al limone. Cioccolatini erano sempre alla sua portata in una coppa sulla scrivania e apprezzò a tal punto il parrozzo (tipico dolce abruzzese) da dedicargli dei versi.[77]
Il pomeriggio era solito prendere il tè o un caffè e latte (tè e caffè sempre con moderazione). Negli ultimi anni si ritirava nello studio verso mezzanotte e si faceva portare biscotti inglesi, mele cotte e il latte. Alle tre di notte capitava che il poeta mandasse agli amici cioccolatini, fiori e inviti a pranzo per il giorno dopo.[68]
Ai grandi ristoranti preferiva le trattorie, sempre lodandone la familiarità con cui venivano preparate le pietanze.[78]
Citazioni erroneamente attribuitegli[modifica | modifica wikitesto]
- Nando Martellini, celebre telecronista sportivo e giornalista, lodando il lungomare principale di Reggio Calabria quello che sarà poi chiamato lungomare Falcomatà (in onore del sindaco della città calabrese Italo Falcomatà), il quale rappresenta una "passeggiata" dove arte e natura si fondono, attribuì a Gabriele D'Annunzio la definizione dello stesso come il più bel chilometro d'Italia, anche per via del miraggio della fata morgana, un fenomeno ottico stranissimo che permette di vedere immagini ravvicinate della Sicilia riflesse dal mare tanto nitide da sembrare vere. In realtà la citazione è apocrifa e D'Annunzio non visitò mai Reggio Calabria.[79]
Omaggi[modifica | modifica wikitesto]
- Gabriela Mistral, poetessa cilena, assunse questo pseudonimo in onore dei suoi due poeti preferiti, Frédéric Mistral e Gabriele D'Annunzio, appunto.[80]
- Dal 21 al 23 giugno 2013 si è tenuto a Gardone Riviera, in occasione del 150º Anniversario dalla nascita del Vate, una manifestazione sportiva e culturale con automobili d'epoca (grande passione che il poeta D'Annunzio manifestò durante il suo soggiorno proprio a Gardone Riviera dove tuttora rimangono custodite due delle sue numerose automobili). La manifestazione, denominata Coppa Gabriele D'Annunzio, prevede anche la sosta presso la dimora del Vate e il pranzo all'interno del Parco del Vittoriale.
- Il portale web dell'Aeronautica Militare ha proposto una pagina, intitolata "I grandi aviatori", dove vengono citate le maggiori personalità storiche dell'aviazione italiana, ponendo D'Annunzio tra di esse.[81]
- Lo scrittore e paramilitare giapponese Yukio Mishima tradusse nella sua lingua Il martirio di San Sebastiano e venne soprannominato il "D'Annunzio giapponese".[82]
Neologismi da lui coniati[modifica | modifica wikitesto]
Fu lui a stabilire in Italia, tra le tante varianti che allora si usavano, che la parola "automobile" fosse di genere femminile: lo fece in una lettera inviata a Giovanni Agnelli che gli aveva posto l'annosa questione ("L'Automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice; ha inoltre una virtù ignota alle donne: la perfetta obbedienza").[83] Fu D'Annunzio che italianizzò il sandwich chiamandolo tramezzino.[84] Fusoliera, velivolo e folla oceanica sono espressioni che introdusse lo stesso Vate.[21] Arzente, italianizzazione del termine cognac, per Gabriele D'Annunzio avrebbe dovuto essere derivato da "arzillo" e da ardens(ardente) a indicare lo stato di euforia indotto dall'ebbrezza, o il calore che derivava dal bere l'alcolico.[85] Inventò il nome proprio Cabiria per l'eroina dell'omonimo film muto del 1914 del quale firmò la sceneggiatura, il nome proprio Ornella e lo pseudonimo della scrittrice di romanzi rosa Amalia Liana Negretti Odescalchi, in arteLiala: il suo nome d'arte si deve proprio a un suggerimento di D'Annunzio: "Ti chiamerò Liala perché ci sia sempre un'ala nel tuo nome".[86]. Fu D'Annunzio a coniare il termine Milite ignoto (dal latino miles ignotus, cioè "soldato sconosciuto")[40] e, verso la fine della Grande guerra, vista la vittoria italiana sul Piave, il poeta decise che il sacro fiume d'Italia doveva cambiare l'articolo: se in passato il fiume era conosciuto come la Piave, fu dopo l'intervento di D'Annunzio che il fiume si chiamerà ilPiave. D'Annunzio ebbe questa idea per celebrare la potenza maschia del fiume che resistette al nemico e il Piave fu elevato a fiume sacro della Patria.[87] Nel 1917 ribattezzò la Rinascente dopo la ricostruzione seguita all'incendio che l'aveva completamente distrutta.
L'attività pubblicitaria di D'Annunzio[modifica | modifica wikitesto]
D'Annunzio fu un grande pubblicitario oltre che coniatore di neologismi. Anche il nome de La Rinascente, per gli omonimi attuali grandi magazzini di Milano, fu suggerito da Gabriele D'Annunzio a Senatore Borletti quando quest'ultimo rilevò l'attività commerciale ivi presente, i magazzini "Aux Villes d'Italie". (Il nome si rivelò poi particolarmente indovinato quando la Rinascente fu distrutta da un incendio e completamente ricostruita).[88] Fu testimonial dell'Amaro Montenegro che definì «liquore delle virtudi»[89] e dell'Amaretto di Saronno.[90] D'Annunzio lanciò una propria linea di profumi, l'Acqua Nunzia.[91] Coniò il nome Saiwa per l'azienda di biscotti.[89] D'Annunzio coniò inoltre il termine "fraglia", unione dei termini "fratellanza" e "famiglia", che indica oggi molte associazioni veliche, tra cui la Fraglia della Vela di Riva del Garda.[92] Per la famiglia di industriali Caproni, pionieri del volo, coniò il motto, scritto sopra un caprone rampante: "Senza cozzar dirocco".[93]
Cinema[modifica | modifica wikitesto]
Maciste, il nuovo eroe di D'Annunzio[modifica | modifica wikitesto]
D'Annunzio creò anche un celebre eroe cinematografico: Maciste.[94] Tra il 1913 e il 1914 D'Annunzio firma un contratto cinematografico con il regista Giovanni Pastrone e l'attore Bartolomeo Pagano per la creazione di un kolossalitaliano che faccia testa alle grandi opere dell'americano David W. Griffith. Il soggetto è tratto dal romanzo Cartagine in fiamme di Emilio Salgari (morto suicida da qualche anno), dal romanzo Salammbô di Gustave Flaubert e da alcune cronache dell'Ab Urbe Condita dello scrittore augusteo Tito Livio. Il titolo, scelto dallo stesso D'Annunzio sarà Cabiria in merito del nome della protagonista "nata dal fuoco" della guerra tra Roma e Cartagine; tuttavia mancava un protagonista maschile che tenesse testa a quello femminile. Studiando gli archivi della storia, D'Annunzio scoprirà un poco noto eroe dell'antica Grecia di nome Mecisteo: uomo il quale si diceva avesse una forza sovraumana.[94]D'Annunzio allora, come i moderni Superman e Spiderman creerà un eroe forzuto e vendicativo però dal cuore tenero dedito soltanto a proteggere le belle fanciulle e gli indifesi dai soprusi dei potenti e dei malvagi.[94] Nasce così, per il film, Maciste, l'eroe dal cuore d'oro, sullo sfondo del disgraziato Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes e dei cavalieri paladini dell'epoca di Carlo Magno e del ciclo bretone e arturiano di romanzi d'avventura.[94]
Nel 1915 Pagano e Pastrone, sempre ispirandosi al soggetto di D'Annunzio, gireranno il film Maciste, l'eroe buono, con protagonista il fortunato personaggio.[94]Tale figura sarà la star di molti fortunati film muti che si propagheranno dal periodo degli anni venti fino al 1965. Nei soggetti originali Maciste è uno scaricatore di porto (forse ispirato da una figura reale, uno dei camalli del porto di Genova)[94] del presente il quale sconfigge dei banditi e dei crudeli imprenditori, mentre daglianni cinquanta ai sessanta, con l'avvento in Italia del cinema peplum e kolossal, il personaggio di Maciste verrà condotto indietro nel tempo all'epoca della Grecia mitologica di Omero ed Esiodo, venendo spesso confuso nelle azioni e nelle sceneggiature con l'eroe forzuto Eracle (Ercole).[94]
Nel 1915 Pagano e Pastrone, sempre ispirandosi al soggetto di D'Annunzio, gireranno il film Maciste, l'eroe buono, con protagonista il fortunato personaggio.[94]Tale figura sarà la star di molti fortunati film muti che si propagheranno dal periodo degli anni venti fino al 1965. Nei soggetti originali Maciste è uno scaricatore di porto (forse ispirato da una figura reale, uno dei camalli del porto di Genova)[94] del presente il quale sconfigge dei banditi e dei crudeli imprenditori, mentre daglianni cinquanta ai sessanta, con l'avvento in Italia del cinema peplum e kolossal, il personaggio di Maciste verrà condotto indietro nel tempo all'epoca della Grecia mitologica di Omero ed Esiodo, venendo spesso confuso nelle azioni e nelle sceneggiature con l'eroe forzuto Eracle (Ercole).[94]
Filmografia di e su Gabriele D'Annunzio[modifica | modifica wikitesto]
Film biografici[modifica | modifica wikitesto]
Oltre ai film tratti da sue opere, D'Annunzio è apparso anche in film biografici e storici, tra cui:
- D'Annunzio (1986) di Sergio Nasca
Film tratti dai soggetti di D'Annunzio e da lui sceneggiati[modifica | modifica wikitesto]
- Francesca di Rimini (The Two Brothers, 1908) di James Stuart Blackton
- Francesca da Rimini (1910) di James Stuart Blackton (remake)
- L'innocente (1911) di Edoardo Bencivenga
- La nave (1912) di Edoardo Bencivenga
- Cabiria (1914) di Giovanni Pastrone
- Maciste (1915) di Luigi Romano Borgnetto
- The Devil's Daughter (La figlia del Diavolo - 1915) di Frank Powell
- La crociata degli innocenti (1917) di Alessandro Blasetti
- La nave (1921) di Gabriellino D'Annunzio (remake)
- Il delitto di Giovanni Episcopo (1947) di Alberto Lattuada
- L'innocente (1976) di Luchino Visconti
Altro[modifica | modifica wikitesto]
Un film softcore erotico del 1921, con le didascalie attribuite a Gabriele D'Annunzio (in realtà opera dei due registi, che si finsero invece essi stessi il figlio Gabriellino D'Annunzio), ha tra i protagonisti un attore-sosia, che interpreta un frate, e viene spacciato per D'Annunzio stesso.[95][96] Il regista erotico Tinto Brass ha dichiarato invece di voler girare un film, che vorrebbe intitolare Eja, eja, alalà, e dovrebbe raccontare la notte di D'Annunzio precedente l'impresa di Fiume.[97]
Citazioni nella cultura di massa[modifica | modifica wikitesto]
- Il cantautore abruzzese Ivan Graziani cita D'Annunzio due volte nelle sue canzoni: nell'omonimo pezzo Gabriele D'Annunzio, che parla di un rozzo contadino che è curiosamente omonimo del celebre poeta, e in Signora bionda dei ciliegi, nel quale viene nominato un "divano dannunziano".[98] Inoltre, la canzone Il lupo e il bracconiere è ispirata a una novella di D'Annunzio.[99]
Onorificenze[modifica | modifica wikitesto]
Onorificenze italiane[modifica | modifica wikitesto]
| Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia | |
| «Cielo del Carso, 19-26 agosto 1917» — 3 giugno 1918,[100] R.D. n. 72/1918 |
| Ufficiale dell'Ordine militare di Savoia | |
| «Cielo di Vienna, 9 agosto 1918» — 10 novembre 1918,[100] R.D. n. 87/1918 |
| Croce al merito di guerra (3 volte) | |
| Medaglia d'Oro al Valor Militare | |
| «Volontario e mutilato di guerra, durante tre anni di aspra lotta, con fede animatrice, con instancabile opera, partecipando ad audacissime imprese, in terra, sul mare, nel cielo, l’alto intelletto e la tenace volontà dei propositi – in armonia di pensiero e d’azione – interamente dedicò ai sacri ideali della Patria, nella pura dignità del dovere e del sacrificio.» — Zona di Guerra, Maggio 1915-Novembre 1918 |
| Medaglia d'argento al valor militare (5 volte) | |
| — Adriatico, Maggio 1915-Febbraio 1916, Veliki-Faiti, 10 ottobre-3 novembre 1916 - Cielo Carsico, Maggio 1917 - Buccari 10-11 febbraio 1918, Cielo Carsico-Timavo, Maggio 1917 |
| Medaglia di bronzo al valor militare | |
| — Bocche di Cattaro 4-5 ottobre 1917 |
| Promozione per merito di guerra (3 volte) | |
| — Veliki e Faiti, Azione notturna su Pola, Organizzazione 1º Squadriglia aeronavale (Sufficit Animus) |
| Mutilato e Invalido per Servizio prestato in Campagna | |
| Medaglia commemorativa della guerra italo-austriaca 1915 – 18 (4 anni di campagna) | |
| Medaglia commemorativa dell'Unità d'Italia | |
| Medaglia commemorativa italiana della vittoria | |
| Medaglia d'oro commemorativa della Spedizione di Fiume | |
Onorificenze straniere[modifica | modifica wikitesto]
| Cavaliere dell'Ordine della Legion d'Onore francese | |
| — 1915-1918 |
| Croce di Guerra 1914-1918 francesi (3 volte) | |
| — 1914-1918 |
| Cavaliere d'Onore e Devozione del Sovrano Militare Ospedaliero Ordine di Malta | |
Titoli nobiliari e militari[modifica | modifica wikitesto]
| Principe di Montenevoso | |
| — Conferito con Regio Decreto del 15 marzo 1924 / 1915-1920 |
| generale Onorario di Brigata Aerea | |
| — Conferito con Regio Decreto del 1925 / 1915-1918 |
| Appuntato ad honorem della Guardia di Finanza | |
| — Conferito con Regio Decreto del 1925 / Fiume 25 giugno 1920 Fonte Wikipedia |

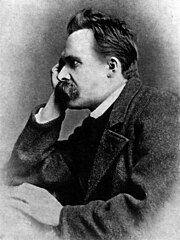







Nessun commento:
Posta un commento